Un discorso sul mondo e un discorso sull’arte: un’intervista ad Alessandro Tota
Abbiamo intervistato Alessandro Tota, chiacchierando della sua idea di narrazione di realtà, divagando tra il cinema e la letteratura, passando per la rappresentazione dell’Italia e chiedendosi se un libro può finire bene anche se i suoi protagonisti si fanno le pere.

foto di Lorenzo Ghetti
Partirei con un cappello introduttivo. Perché i tuoi fumetti oscillano un po’ sulla linea tra il fumetto di realtà e l’autofiction… Com’è nata questa sensibilità, questa poetica?
Secondo me c’è molto di emulativo in quello che si fa. Moltissime delle forme che noi usiamo in quanto narratori sono le forme che ci circondando, realizzate dai nostri contemporanei, che in qualche modo vanno a validare una certa possibilità, la rendono concreta e accettabile. E poi ci sono delle influenze che vengono dai primi amori della giovinezza.
Io nasco con Frigidaire, cioè con un tipo di fumetto che cerca di rapportarsi alla realtà in maniera abbastanza punkettona, abbastanza aggressiva. Questo mi ha formato e ha determinato il mio gusto. Se fossi stato del partito di Valvoline, come Fior per esempio, avrei preso un’altra direzione.
Poi c’è stato l’underground americano. E l’underground è stato l’autobiografia, soprattutto con Crumb. Un’autobiografia in cui non c’era soltanto l’intimismo un po’ sognante, del genere “sto in camera mia e soffro un casino”.

Per Crumb il partito preso era: “svuoto il sacco”. Questi sono i miei primi amori nel fumetto: Frigidaire e l’underground.
Poi naturalmente c’è la letteratura, perché è impossibile pensare al mio lavoro senza l’influenza che la letteratura americana ha avuto sulla mia generazione. Parlo della grande tradizione dell’autofiction: Roth, Fante, Bukowski e accanto a loro penso a Carver. Per quanto riguarda Carver, la sua influenza può rivelarsi un’arma a doppio taglio: da un lato il minimalismo ti dice che puoi raccontare anche quello che succede nella casetta dei vicini, ma spesso si trasforma in “puoi raccontare soltanto quello che succede nella casetta dei vicini”. Invece per quel che riguarda Roth e Fante, il discorso è più complesso perché le strategie sono più complesse, soprattutto in Roth. C’è il lavoro sulla personalità e la costruzione dell’alter ego narrativo. Un lavoro per cui serve un carattere tutto speciale, un narcisismo incredibile e una capacità spaventosa di prendersi per il culo. Questo nel mio caso è stato fondamentale. Fondamentale, anche come limite.
L’assist allora è abbastanza diretto. Se penso a Yeti e a Fratelli, nessuno dei due è dichiaratamente autobiografico. Però in Yeti c’è Volker che è proprio Volker [Zimmermann], e poi ci sei tu. Che non ti descrivi, diciamo, in maniera proprio proprio positiva…
Direi che nel libro sono un pezzo di merda!

Madonna, davvero! E poi ci sono molto rimandi a esperienze personali, ad ambienti vissuti… Anche se poi c’è uno yeti senza pelo in centro a Parigi. Ma quindi esiste un confine tra una narrazione della realtà, che però rimane comunque nel campo della fiction, e l’autofiction?
Quindi vuoi sapere di Yeti.
Si può partire da Yeti, ma un discorso analogo lo si può fare anche per Fratelli.
Allora. Fino ad ora, con eccezione dei miei libri per bambini e de Il ladro di libri, è facile trovare gli elementi autobiografici nel mio lavoro. Luoghi, persone, volti…

Yeti è chiaramente tutto basato sul gioco, perché se io uso la mia ragazza, uso uno dei miei migliori amici, uso anche me… per come sono io impersonerò sempre il cattivo, non mi ci vedo a fare il buono.
Ho fatto moltissimi diari, che sono veri diari a fumetti, che sono inediti, tranne una piccola scelta che Igort mi chiese per Black. Cosa significa dei veri diari? Che sono una specie di continua interrogazione su quello che stava avvenendo nella mia vita, senza necessariamente comprenderlo. Quindi spesso si vanno a toccare questioni o aspetti del mio carattere che non posso esporre in pubblico, perché quella cosa lì la fai solo dallo psicologo. Ci sono persone che fanno più autoanalisi e altre che ne fanno meno, è una tendenza caratteriale, suppongo. Io fino a un certo punto ho sentito molto questa esigenza. Poi quando ho cominciato a fare i romanzi, i libri hanno praticamente sopperito a quel bisogno e ho smesso con i diari.

Ed è un fatto molto naturale, se ci pensi, che il passaggio non sia subito alla fiction completa. È graduale: prima facevo i diari, poi ho cominciato a fare i libri e ho preso elementi biografici e li ho mischiati con elementi di finzione, e poi ho fatto Il ladro di libri e i libri per bambini che sono storie inventate. Chiaramente però anche nei libri per bambini… In Caterina, la serie che ho fatto per Dargaud, la protagonista è mia moglie e i comprimari sono Luigi Critone e Manuele Fior. È difficile lavorare completamente in astratto.
Tempo fa ho fatto un nuovo fumetto autobiografico, ma è finto. È un montaggio di situazioni reali che vanno a comporre una storia inventata. Quindi è vero che ormai il confine è stato passato e non si torna più indietro, cioè non avrò mai più la capacità di fare un fumetto veramente autobiografico: se dovessi sentire quel bisogno probabilmente andrei dall’analista invece che mettermi a scrivere. Certo nei taccuini di ogni autore ci sono delle riflessioni, ma non è una cosa sistematica, come lo era per me prima.
Una cosa bellissima che pochi libri riescono a fare è destabilizzarti. Destabilizzare alcune consuetudini che si hanno quando si pensa a cos’è una brava persona, per esempio. La propria vita è un laboratorio interessante per lavorare col racconto e andare in quella direzione, distruggendo i preconcetti…

Un’altra cosa che stavo pensando… Fratelli, per esempio, ha una caratterizzazione temporale e georgrafica molto precisa. Però anche se io quegli anni non li ho vissuti e non sono stato mai a Bari, quella storia riesce a parlarmi. Però non c’è il rischio che, a caratterizzare così precisamente i luoghi e i tempi, il racconto perda trasversalità?

Nelle mani di un buon autore anche il locale diventa universale. Poi magari non ti fila nessuno lo stesso, però se la costruzione è forte, gli ambienti e le immagini sono messe a fuoco e soprattutto c’è una storia forte, il messaggio arriva sempre. Pensa a Elena Ferrante. La gente impazzisce perché legge dell’Italia. O pensa a Fellini.
O alla letteratura russa… per esempio a volte può capitare di leggere Tolstoj, che parla di certi dettagli, e non capire neanche di che stia parlando, ma capire cosa quegli oggetti significhino per i personaggi: lusso, desiderio, sacrificio, consuetudine… è in quel modo che trasformi il piccolo in grande. Ma per fare questo bisogna saper creare rapporti tra le cose, creare un universo coerente, avere fantasia, saperti guardare attorno…
L’Italia è difficile da raccontare come tutti gli altri posti. Tutto è difficile. Il fumetto è particolarmente difficile per tanti motivi, e forse l’Italia è stata raccontata poco.
Il cinema offre un po’ più di spunti. Fellini ha raccontato Roma. I giapponesi vedono Amarcord e lo capiscono! Quella è Rimini, chiaramente reinventata, ma più locale di Amarcord cosa c’è? Allo stesso tempo se guardi Drunken Angel, uno dei primi grandi film della maturità di Kurosawa, vedi la Tokyo del dopoguerra, ed è caratterizzata in maniera fortissima. E questo non indebolisce il film. Perché alla fine tutto il mondo è paese e quando parli degli affetti, delle relazioni degli uomini… funzionano dovunque li metti.
Quindi secondo me non è tanto un limite, ma una forza, avere uno sfondo ben caratterizzato. Sarebbe una sfida cercare di raccontare meglio l’Italia. Sorrentino l’ha capito benissimo. Lui si vende come italiano. Lo rivendica: “io sono italiano, questa è la città che filmo. È Roma. Anzi volete vedere una serie sul Papa?”.
Ah questa è una cosa molto interessante… ma com’è che raccontare la realtà è così difficile?
Questa è una cosa che credo di avere già detto altrove, credo ad Hamelin, ed è quello che mi piacerebbe vedere come lettore e la direzione verso cui spero di andare come autore. C’è stato un grave misunderstanding: noi non dovevamo guardare alla letteratura per fare il romanzo a fumetti, ma per liberare il linguaggio.
Dovevamo guardare alla letteratura come ambizione, non per riprodurre il modello del romanzo. Perché poi quando abbiamo voluto fare il romanzo a fumetti, la maggior parte delle volte abbiamo fatto i film a fumetti, mica il romanzo. Invece se tu vedi Roth quando racconta Newark, Malaparte quando racconta Napoli, Fante quando racconta Los Angeles, lì c’è l’ispirazione che serve, secondo me. Quello che si può imparare dalla letteratura è l’uso del frammento, la divagazione, la forma breve… Dovevamo guardare alla letteratura, al saggio, alla poesia, nel senso di possibilità di liberarci. Se no finiamo tutti per fare la nostra bella sceneggiatura in tre atti fatta bene, e quello finisce per essere il romanzo a fumetti! Poi, sia chiaro, si possono fare libri bellissimi col modello “tradizionale”. Io stesso ho provato a usarlo quando ho fatto il Ladro di Libri con Pierre Van Hove.
Ma bisognava guardare alla letteratura per poter poi tornare al fumetto rinvigoriti e rileggere i grandi fumetti del passato e fregare tutto il possibile, come infatti hanno fatto Ware, Clowes e qualche altro.
A me piace molto Bacilieri. Quando si è messo a raccontare Milano e ha fatto quelle storie per Animals, che poi sono state raccolte in Fun… Quello è un modo di zigzagare e divagare per la città che è interessante. Ed è proprio quello il vero romanzo a fumetti, non quello a cui pensiamo di solito. È là che ho voglia di andare, nella frammentazione, anche se per comporre affreschi grandi, anche grandissimi, ma non nel modo che ho usato ne Il Ladro di Libri…

Però c’è una convivenza, anche con una certa frizione, tra forme brevi e forme lunghe. Secondo te c’è una pressione verso le forme lunghe, anche per cose che ne perdono?
La pressione è verso un prodotto funzionale alla distribuzione in libreria, e che vada incontro alle aspettative del lettore. Se a me lettore mi metti in testa che esiste solo il romanzo a fumetti, allora io voglio il romanzo. Il libro piccolo non lo voglio, voglio il tomone di 300 pagine.
Mi sembra di vedere, per quanto riguarda il lavoro degli autori più giovani, un nuovo interesse per la forma breve. O comunque per altri formati e idee di libro. Perché il romanzo a fumetti per gli autori è una mezza fregatura, diciamocelo. È un lavoro pazzesco.

Comunque, io sono la generazione di mezzo, né vecchia né nuova, nasco editorialmente col romanzo a fumetti, per cui probabilmente cercherò di declinarlo in modi nuovi ma probabilmente ne farò diversi altri anche lunghi, se gli editori mi danno retta.
Mentre dicevi questa cosa ho immediatamente pensato a come è stato recepito il libro di Alice Socal, che appena è uscito…
“Ma non è un romanzo!”.
Precisamente. “Eh ma non è un graphic novel, è troppo corto, graphic novella sarebbe meglio…”. Mi pare che sempre, quando si riflette su queste cose, lo si faccia da un punto di vista puramente merceologico invece che di respiro e funzioni narrative. Ci siamo rimasti sotto a questa storia del “graphic novel”, abbiamo finito per crederci pure noi.
L’editoria è fatta di formati e di standard. Un editore può dirti anche “adesso si fanno i romanzi a fumetti, se vuoi esistere devi fare il romanzo a fumetti”. E allora l’autore dice “vabbè, anch’io faccio il romanzo a fumetti. Allungo il brodo”. Tanto 150-200 pagine le caghiamo. Ma il rischio è che diventi un altro romanzo a fumetti tra le centinaia di romanzi a fumetti che ci sono.

L’industria cerca di limitare le differenze, di farti rientrare in delle categorie, perché è il ruolo dell’industria. Ma il ruolo dell’arte non è piegarsi all’industria. Poi puoi piegarti con stile, per carità, tutto dipende dal modo in cui fai le cose, non è che devi essere necessariamente Van Gogh. Magnus ha lavorato nell’industria tutta la vita e ha fatto capolavori.
Però quando entro in una libreria francese, non li guardo nemmeno più i romanzi a fumetti pubblicati dai grossi editori, sono tutti uguali. Sono tornato, come dieci anni fa, a guardare solo gli indipendenti.
La qualità media è molto alta, di autori talentuosi ce ne sono tantissimi, ma forse il talento non è un elemento sufficiente a creare opere che rimangono. O almeno suscettibili di attirare la mia attenzione. Quello che cerco nei libri è sì il talento, ma anche un certo atteggiamento nei confronti dell’arte, della vita che emerga dai libri. Sennò è solo un libro bello, e il mondo è pieno di libri belli. La bellezza non basta, almeno per me. L’ideale è un autore che faccia un discorso: un discorso sul mondo e un discorso sull’arte, se mi passi l’espressione mutuata alla Nouvelle Vague. Un autore con cui avere un dialogo, con cui crescere. Insomma sono per una relazione stabile e non per una botta e via.
Mi riaggancio a una cosa che dicevi nella chiacchierata con Manuele Fior del numero 42 di Hamelin, che è difficile raccontare la felicità. Anche i tuoi libri non sono esattamente un tripudio di gioia…
Però fanno quasi tutti ridere, o almeno spero.

A tratti fanno anche ridere, sì. Però c’è sempre quel sottotesto… Non so, penso anche ad opere come Beverly, dove viene raccontato un disagio e una bruttura e una decadenza opprimenti dai quali sembra che non si possa scappare… Com’è che è più interessante leggere e raccontare la gente che sta male?
Ci sono due diverse riflessioni da fare. Da un lato c’è una tradizione del racconto intimista un po’ triste che viene dal minimalismo di Carver e tanti altri. È un genere, e ci si può lavorare attorno. E va bene. Poi c’è la volontà di fare un discorso senza sconti sulla nostra società. Dire “è una merda, i rapporti umani fanno schifo, il mondo del lavoro fa schifo, c’è l’inquinamento, siamo governati nel migliore dei casi da incapaci”. Questa è una critica radicale al sistema, ed è legittima. Per cui, ben vengano i libri così se fatti bene.
Io però sono italiano e sono nato nell’82. Non posso mettermi a copiare Chris Ware. Sono cresciuto col cinema italiano, con la commedia italiana degli anni 50 e 60, che vedeva mio padre. Sono commedie in cui ti fai un sacco di risate, ma poi ci pensi e vuoi piangere. Un esempio: I Compagni, di Monicelli, film su uno sciopero in una fabbrica di fine ‘800. È considerato una commedia. Ma è impressionante la spietatezza con cui descrive i rapporti. Il riso e il pianto vanno assieme. Non mi libererò e non voglio liberarmi da questa influenza. Me lo tengo stretta.
Per arrivare ai miei libricini: Yeti è chiaro che finisce male. Anzi, i miei libri finiscono tutti male: Yeti è “l’integrazione impossibile”; in Fratelli quelli si fanno le pere e quegli altri si vendono la roba della madre; Il ladro di libri è un disastro su tutta la linea, anche se lui trova una specie di felicità; in Charles non va bene con la ragazza… Però è come tutto quel tipo di commedia classica in cui la realtà viene rappresentata nella sua violenza, senza fare il drammone, ma facendo ridere. Ma forse è la commedia che è così… in Manhattan di Woody Allen la storia con la ragazza non finisce bene, se vedi Amore e guerra alla fine Woody Allen muore.
Quindi è una scelta stilistica?
Possiamo dire così. È come sono io come persona.
Però dai, Fratelli è vero che fa sorridere e anche ridere, in più punti. Ed è vero che c’è una violenza di fondo, però alla fine io non ho percepito che finisse male. Ci sono delle aperture verso una positività…
Sì, c’è qualche spiraglio. [ride]
Lui comunque si tira un po’ fuori. Sì, ok, si fan le pere…
E che sarà mai! [ride]

Però quantomeno si ferma prima di mostrarti il tracollo definitivo della persona, no?
Certo.
Ma è comunque una situazione di disagio, che fa ridere e finisce forse bene e forse male, ma è una situazione pesa. È possibile raccontare una situazione di non disagio?
Taniguchi l’ha fatto: L’uomo che cammina è un libro… è la vita: le esperienze della vita affrontate in maniera positiva. Ci sono sicuramente film che fanno questo. È che gli esempi sono meno numerosi. Forse ci vuole una grande maturità per raccontare la felicità senza apparire sciocchi. Come se io facessi un diario in cui mi va tutto bene. Ma ti pare? Anche se forse avrebbe successo!
Comunque c’è narrazione quando lo scorrere tranquillo degli eventi si interrompe. È una regola di base. La narrazione funziona spesso per contrasti. La felicità la dai per togliergliela, o gliela togli per dargliela. È un gioco. Se la situazione del personaggio è costante non c’è narrazione, non c’è conflitto.
Poi noi europei abbiamo nell’arte del ventesimo secolo una tradizione espressionista, che colleghiamo immediatamente all’espressione del disagio. Uno dei grandi temi del ‘900 è stato il conflitto tra l’individuo e la società: in Italia pensa a Svevo, a Pirandello… C’è questa situazione di conflitto permanente. Per cui un po’ l’artista deve stare male, no? Sono tutte idee ricevute.
Poi c’è anche un’altra cosa. Viviamo in una società molto ricca di situazioni narrative diverse che convivono. Anche qui ci saranno delle famiglie di immigrati arabi, ci stanno i marocchini, là stanno gli italiani, gli studenti fuori sede, la pensionata, il bar, il bar dei cinesi, il posto dove si va a scommettere sui cavalli, poi ci sta la chiesa affianco. Tutto in pochi metri quadrati. Puoi fare delle storie in cui attraversi la società, e mi domando com’è che non viene fatto di più. Forse perché anche gli autori sono una categoria molto alienata dalla società. Ma bisognerebbe raccontare di più il mondo. Bisogna raccontare la realtà in maniera non piatta e con più ambizione, nel fare qualcosa che non sia giornalismo. Che si può fare egregiamente, eh, ma al momento sono poco interessato al giornalismo a fumetti. Il fumetto ha bisogno di più fantasia.

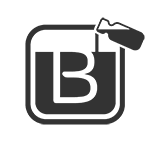





Leave A Comment