Un’impressione di oggettività: un’intervista a Chris Ware
Un’impressione di oggettività è un estratto dell’intervista omonima tradotta da Elena Orlandi e pubblicata da Coconino Press – Fandango nel volume Il palazzo della memoria.
La versione integrale in inglese dell’intervista, di Urs Bellermann, è stata pubblicata nel numero 30 della rivista mono.kultur.

Si definirebbe più un narratore o un fumettista?
A volte penso che non avrei mai nemmeno dovuto provare a raccontare delle storie e avrei dovuto limitarmi semplicemente a disegnare, ma poi provo a disegnare soltanto e mi rendo conto che mi manca qualcosa, e lo stesso succede quando penso che forse avrei dovuto provare soltanto a essere uno scrittore. Ciò che mi spinse per la prima volta a cercare di raccontare delle storie furono le ore che da adolescente passavo con mia nonna, ascoltandola riandare al passato e raccontare di come fosse cresciuta in Nebraska nella prima parte del secolo. Mi raccontava di come avesse incontrato mio nonno, dei loro primi anni di matrimonio, dei ricordi di mia madre da ragazzina, qualsiasi cosa le venisse in mente o le chiedessi io. Con le sue parole riusciva letteralmente a far prendere vita ai ricordi; c’erano volte in cui parlando con lei perdevo la percezione di me stesso e mi sembrava quasi di tornare indietro nel tempo. Il suo senso dell’intreccio era istintivamente raffinato ed equilibrato, e riportava i dettagli più minuti: come l’erba fosse allora più infestata di erbacce, l’odore di legno dei corridoi della Scuola per ciechi del Nebraska dove suo padre faceva il custode, che scocciatura fosse svuotare le teglie di sgocciolamento del mobiletto della ghiacciaia, ogni più piccola cosa.
Aveva anche una sintassi originale, davvero evocativa, e inventava nuovi significati posizionando i termini in espressioni sorprendenti, in modo simile a quello che ancora fanno i britannici. Il linguaggio inglese mi sembra molto più vitale là che negli Stati Uniti. Facemmo alcuni viaggi in macchina insieme per visitare i posti dove aveva vissuto prima di trasferirsi dal Nebraska, e le storie che quel viaggio evocò in lei sembrava ci trasportassero in un luogo in cui passato e presente non avevano significato. In poche parole, non solo mi fornì un esempio di come raccontare le storie, ma mi mostrò anche il loro valore. Mi sentivo sempre più radicato ed empatico nei confronti degli altri dopo aver passato tempo con lei, più vicino a mia madre, e in generale una parte del tutto, che non è necessariamente una sensazione che l’adolescenza incoraggia.
Ciò detto, l’unica cosa che non voglio essere è un narratore, che per me indica, più o meno, la capacità di correlare eventi e trama: penso che mia nonna scrivesse davvero, raccontandomi le sue storie. Scrivere, per me, organizza i fatti in un tessuto che li intreccia insieme ai sentimenti, le sensazioni e la consistenza delle esperienze reali, e si attiene, direttamente o poeticamente, allo svolgersi della vita così come sembra o è sembrato che si sia svolta. L’esempio più semplice della differenza tra le due cose è confrontare Tolstoj e Dickens, se si escludono alcuni passaggi ricchi ed evocativi di Dickens, tipo la sequenza del temporale in David Copperfield. Tolstoj, uno scrittore, tesse con attenzione ogni cosa in un arazzo di esperienza che sembra la diretta trascrizione della vita. Dickens in genere, ma non sempre, ti dà i dettagli principali e porta avanti la trama. Suppongo che James Joyce sia l’esempio definitivo di scrittura, dato che l’Ulisse è praticamente un testo alchemico, e impianta ricordi sensoriali nella mente del lettore senza dirgli nemmeno cosa è successo, anche se il lettore finisce intuitivamente per ricavare un qualche senso di azione. Non ho assolutamente idea di come sia riuscito a farlo.

È una discriminante interessante. Quindi disegnare è davvero scrivere nel suo caso?
Sì, senza dubbio. Negli anni, ho cercato di applicare il concetto del linguaggio scritto al fare fumetti, approcciando il disegno più o meno tipograficamente. Ovviamente i fumetti erano proprio questo, fin dall’inizio, ma io imparo lentamente e ci sono arrivato da una serie di punti sconclusionati.
In un primo momento, cercavo di ottenere quella tipica mancanza di vita di cui fumettisti come Ernie Bushmiller, Lyonel Feininger e Fletcher Hanks – e in maggiore o minore misura Bob Kane e Ray Gotto – hanno imbevuto il loro lavoro. Riconosco un’eternità molto strana, vibrante, nella maggior parte delle loro illustrazioni, un’immobilità perpetua che sembra donare alle loro immagini una qualità più pittografica e leggibile. Ho cercato di emularlo attraverso la composizione o con linee intenzionalmente grossolane, brusche, o in entrambi i modi.
Quand’ero un aspirante pittore a scuola, scoprii che semplicemente non riuscivo a smettere di usare le linee, cosa che nel mondo delle arti figurative è assolutamente inaccettabile, un’assurdità ovviamente, ma ai tempi non lo sapevo. Non ero in grado di lasciare che le cose sfumassero le une nelle altre, perché quello che volevo davvero ottenere era un’impressione di oggettività in tutte le cose. Che è un altro tabù del mondo delle arti figurative – il più grande di tutti.
Allo stesso tempo, disegnavo molto dal vero nei miei quaderni di schizzi, seguendo l’esempio incontestabile di Robert Crumb, e scoprii che disegnare dal vero e disegnare per i fumetti erano due cose molto diverse: la prima significa cercare di vedere ogni dettaglio della vita, e la seconda cercare di ridurlo a come ce lo ricordiamo. Inoltre non volevo che il lettore si fermasse ad ammirare la bellezza delle singole immagini, ho sempre voluto che continuasse ad andare avanti, continuasse a leggere. Quando si legge un testo, non ci si ferma ad ammirare le singole lettere o le parole: si va avanti come mezzi ciechi e ci si perde nella storia.
In questo senso devo ammettere una certa superiorità del testo sulle immagini, perché le immagini possono davvero limitare piuttosto che ampliare il grado in cui un lettore può empatizzare con un personaggio e una storia. Inizialmente ho cercato di aggirare quello che pensavo fosse il problema non mostrando le facce dei personaggi – le vestigia di questa scelta sopravvivono in Jimmy Corrigan, eccetto nel caso dei personaggi principali. Jimmy è spaventato dalle donne, soprattutto da sua madre. Penso che trovassi la presenza su una pagina a fumetti di facce che mi fissavano molto disturbante e caotica sul piano empatico. Mi sembrava soltanto che, per empatizzare davvero con un personaggio, meno informazioni si avevano meglio era, e che forse questo fosse il motivo per cui così tanti personaggi delle strisce popolari erano calvi e sembravano dei neonati, come Charlie Brown, Tintin, Barnaby, Henry, etc. Ho disegnato la copertina per il centesimo numero del The Comics Journal trasformando in scenetta comica questo concetto.

Ho anche deliberatamente evitato di pensare alla tavola come all’obiettivo di una cinepresa, che è un artificialismo cinematografico che penso abbia bloccato la crescita dei fumetti per decadi, anche se ora è una metafora che abbiamo tutti quanti interiorizzato. Per esempio, chi non ha avuto il sogno di fare un film? Trovo che il modello più teatrale dei fumetti di inizio secolo – dove i personaggi sono disegnati a figura intera, senza tagli di inquadratura, e non ci sono quasi mai cambiamenti di scala – sia molto più onesto e in sintonia con quello che io penso sia la vita vera. E questo approccio permette alle immagini su pagina di diventare vive molto più velocemente, tra l’altro: diventano disegni in sé piuttosto che immagini di cose.
Infine, in precedenza avevo smesso del tutto di usare il testo nei miei fumetti perché mi ci affidavo come a una gruccia piuttosto che come a uno strumento, quindi ho cercato di raccontare storie usando solo le immagini, cercando di raggiungere ciò che ero arrivato a pensare come una musica che si sente in testa quando si legge una serie di disegni, e di abituarmi a quelle sensazioni e tonalità prima di iniziare a reintrodurre le parole. Questo succedeva tra il 1988 e il 1991.
L’aspetto negativo di tutta questa autoconsapevolezza fu che mi lasciò… be’, molto autoconsapevole, e fu una strada lunga e difficile prima che mi sentissi a mio agio ad affrontare con i fumetti più o meno ogni argomento… davvero, è successo solo negli ultimi cinque anni o giù di lì.
Ma sì, in breve, per me disegnare è scrivere. E se dovessi arrivare a una definizione decisamente rigida e teutonica: i fumetti sono immagini da leggere, non solo da guardare.
Oggi le sue opere, come Lint e Jimmy Corrigan, vengono considerate una faccenda seria, da adulti. Ha sempre voluto che venisse visto così?
Tristemente, direi di sì, e questa ambizione è sempre stata un intralcio perché, sommandola alla mia educazione universitaria, mi ha sempre costretto a combattere costantemente contro la direttiva introiettata a esagerare con le sperimentazioni e a essere troppo pretenzioso. Devo resistere alla tentazione di continuare a correre in avanti con la testa, non continuando a coesistere nel presente con le mie storie e i miei fumetti, cioè il luogo dove ogni scrittore dovrebbe sempre esistere altrimenti i risultati sono sempre manieristi e bizantini.
Invidio chi è totalmente non istruito, o per lo meno non educato ai metodi assurdi della teoria e dell’accademia, che inducono un’atmosfera soffocante e a volte addirittura tossica per l’arte.
A ogni modo effettivamente sono andato all’università per cercare di trovare un modo di scrivere fumetti lunghi per adulti, e di conseguenza mi iscrissi a classi di letteratura e pittura.
I suoi fumetti non sono esigenti soltanto a causa delle loro natura ibrida, ma anche per gli argomenti scelti. Spesso siamo testimoni di intere vite dalla nascita alla morte. Cos’è che le interessa nel seguire i suoi personaggi dall’inizio?
Penso dipenda dalla storia, anche se c’è una cosa che generalmente perseguo è provare a creare qualcuno che sembri presente, vulnerabile e reale. Non progetto un personaggio fin dall’inizio. Ma a ogni modo lui o lei in un certo modo si accumulano nei miei pensieri quotidiani finché a un certo punto realizzo che sto scrivendo una storia su qualcuno che non ho mai incontrato. Forse è una specie di malattia mentale. A oggi, penso allo stesso gruppo di persone immaginarie da più di una decade, quindi è ovvio che non posso essere completamente sano. Penso che la maggior parte della narrativa venga da quello stesso luogo in cui immagazziniamo le impressioni generali e le persone che sbucano spesso nei nostri sogni, o dai momenti quando impersoniamo o imitiamo gli altri, così come dal perpetuo “e se”, che è una piaga per tutti noi, tipo: “E se tradissi mio marito?” o “E se mi uccidessi?”.
In modo ancora più importante, però, cerco di indurre un senso di empatia per tutti i personaggi, che siano apparentemente buoni o cattivi, anche se, di nuovo, questo dipende anche dalla modalità della storia, e se è narrata dall’interno o dall’esterno, ma penso di percorrere raramente la seconda strada.
Paul Thomas Anderson in un’intervista anni fa disse qualcosa riguardo l’innamorarsi di un personaggio, e quella probabilmente è la risposta più concisa: immagino di pensare che se non mi innamoro dei miei personaggi allora non vale la pena scriverne.
Intervista pubblicata originariamente nel numero 30 della rivista mono.kultur. Per l’occasione è stato realizzato anche un poster di grande formato acquistabile qui.
Un estratto dell’intervista originale, tradotto da Elena Orlandi, è contenuto nel volume Il palazzo della memoria, pubblicato da Coconino Press – Fandango.

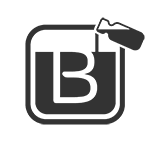



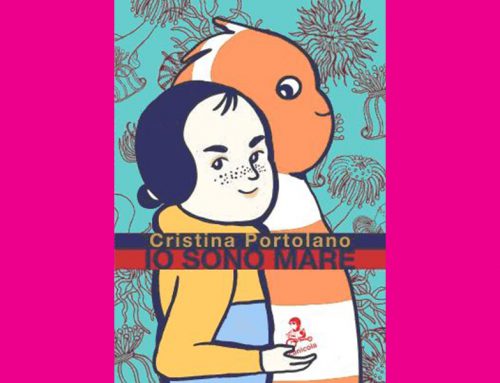

Leave A Comment