L’attrazione per il raccapriccio
di Anna Verrengia

Capita, per esempio nella visione di un film, di trovarsi davanti a scene violente e/o disgustose ma al contempo di non riuscire a distogliere lo sguardo, restando affascinati e angustiati dallo spettacolo in corso. Magari si rimane sconcertati e se ne disapprova apertamente la disumanità ma, nonostante il ribrezzo, si indugia incollati a quello schermo incapaci di porre un freno alla curiosità, stupiti dalla propria fascinazione per il raccapriccio, dal proprio interesse. È cosa comune, si potrebbe dire perfino universale, che investe non solo il campo della cinematografia ed in generale delle arti visive, ma anche quello più vasto della letteratura: film, libri, illustrazioni e fumetti dall’inequivocabile contenuto gore, con scene di torture, stupri, omicidi, violenza anche gratuita, infida e sottile. Un fenomeno molto diffuso, oggi più che mai.
La questione degna di interesse è la compresenza ossimorica di piacere e disgusto, di attrazione e repulsione: si ricerca nel prodotto artistico ciò che il nostro corpo vorrebbe istintivamente e naturalmente allontanare. Ma soprattutto, si ricerca nella finzione quello che nella realtà sarebbe totalmente bandito, oggetto di biasimo e condanna.

Perché questo avviene? Perché troviamo appagante sul piano artistico ciò che nella vita reale ci repellerebbe? Non è certo possibile fornire un’unica risposta esaustiva: l’univocità rimanda ad un determinismo meccanicistico impossibile da rispettare laddove ci si confronti con la complessità umana. Un’operazione senz’altro più lecita è analizzare i vari e possibili motivi che possono spingerci a ricercare contenuti osceni e “politicamente scorretti” nei nostri prodotti di intrattenimento. È quello che tenterò di fare.
In primo luogo, certi tipi di letture o visioni rispondono al nostro più o meno consapevole bisogno di sensazioni forti che ci scuotano e risveglino, anestetizzati come siamo dal tran-tran quotidiano. Cadiamo spesso preda di una sorta di circolo vizioso che ci spinge a ricercare dosi sempre maggiori di emozione, per contrastare la noia e sentirci vivi. Prodotti di intrattenimento splatter o gore ci danno adrenalina, tensione, quel tipo di eccitazione che solo l’eccesso e l’estremo fuori dalla norma ci possono dare. La sfida al limite è dunque una componente essenziale di questo tipo di produzioni, che celano neanche troppo velatamente fantasie di onnipotenza su se stessi e sul mondo: si fa astutamente leva sull’esigenza di provare sensazioni nuove ed inedite, di superarsi, di trascendere i propri confini per accedere ad un’altra immagine di sé, più forte e, forse, chissà, anche migliore. D’altronde il limite ci ha sempre affascinato proprio in quanto tale, poiché la sua stessa esistenza implica la possibilità di sfidarlo e superarlo. Sono infatti spesso i giovanissimi che prediligono certi spettacoli, in un’età in cui la ricerca dell’eccesso diviene un modo per confrontarsi e affermare la propria personalità in fieri.

Il superamento del limite non riguarda però solo se stessi e la propria capacità di sperimentare emozioni forti e violente: coinvolge anche la società e le sue leggi. Prodotti artistici particolarmente efferati e crudeli consentono l’incursione in territori inesplorati, dove le abituali ferree regole sociali cessano di esercitare il loro potere, veicolando la nostra carica trasgressiva. Ad attrarci sarebbe quindi il gusto del proibito, l’occasione che questo offre di travalicare i limiti e i divieti imposti dalle norme sociali, morali e impartite dalla nostra stessa coscienza. Fin dalla tenera età, siamo infatti svezzati a suon di “no”, prima dai nostri genitori e poi dal mondo esterno, e così impariamo ben presto ad attenerci alle regole e a soffocare i nostri veri istinti, se in quel momento non sono consoni alla situazione. “In corpo fiele, in bocca miele” direbbe Pirandello.
Attraverso il canale artistico possiamo però incanalare le nostre pulsioni perverse, certi di non incorrere in alcuna disapprovazione interna ed esterna. Si tratterebbe quindi di uno sfogo ammesso e legittimo dei nostri impulsi istintuali aggressivi e proibiti, al riparo dalle conseguenze nefaste che questi avrebbero nella realtà. Un conto è ad esempio avallare atti di estrema efferatezza nella vita quotidiana, un altro godere segretamente, attraverso opere di finzione, della perdita dei freni inibitori che si accompagna all’esplosione selvaggia della violenza. Anzi, proprio il fatto che si tratta di rappresentazioni consente di abbandonarci senza pericolo alle emozioni negative e spiacevoli, anche violente, che la storia suscita, ben consapevoli della natura fittizia della stessa. Così, se da un lato vige l’immedesimazione ed il coinvolgimento empatico con i personaggi della storia, dall’altro agisce il distacco, la distanza dalle vicende narrate; una distanza fisica che può diventare anche spazio di riflessione e metabolizzazione. Questa è anche la base del meccanismo catartico, laddove l’identificazione con i protagonisti delle vicende e con i loro sentimenti e tribolazioni può divenire possibilità per una sorta di purificazione da quelle stesse emozioni: vale a dire, le vicissitudini di seconda mano ci aiuterebbero ad elaborare meglio le proprie. Se poi le atrocità raccontate trovano una giustificazione superiore di ordine morale, come nelle storie di vendetta dei film tarantiniani per dirne una, tanto meglio. Il nostro Super-io, sempre all’erta, può stare quieto. Pur oltrepassando il territorio di ciò che è moralmente accettabile, non ne snaturiamo l’essenza: i buoni trionfano e i cattivi vengono puniti, e ci sentiamo tutti più sollevati. Ecco che personaggi come la Sposa in Kill Bill o Paul Kersey ne Il giustiziere della notte sono veri e propri eroi adorati dal pubblico, benché siano dei violenti assassini sanguinari. E questo perché, nonostante i loro metodi non proprio ortodossi, o forse proprio per questo, mettono a tacere la nostra sete di giustizia sociale.

Certo, simili osservazioni riaprono l’annosa questione della società come contenitore dei nostri impulsi perversi. Freud e gli psicoanalisti ci ammoniscono in tal senso: alla civiltà e alla cultura spetta il primario compito di proteggerci dalla nostra vera natura, anche se a farne le spese è in primis la libertà. Scriveva Jung in Psicologia dell’inconscio:
Com’è noto, il processo di civilizzazione in una progressiva sottomissione della componente animale presente nell’uomo è un processo di addomesticamento che non può essere realizzato senza ribellioni della natura animale, avida di libertà.
In questo senso, questo tipo di fruizione artistica rappresenterebbe una valvola di sfogo a quelle limitazioni poste dalla società.
Nell’impossibilità di stabilire se in ognuno di noi viva un violento assassino inibito, e peraltro lungi da me riuscirci, è certo però che vi sono spinte sotterranee dell’irrazionale che serpeggiano nel sonno della nostra coscienza, e che in un modo nell’altro riaffiorano in forme socialmente sancite. La produzione artistica si porrebbe quindi come ricettacolo non solo dei nostri desideri segreti e delle passioni mai confessate, ma anche delle nostre angosce e delle nostre paure più recondite. La nostra ombra preme per venire alla luce, prendendo in prestito l’espressione junghiana: ad attrarci sono anche le storie in cui vengono realizzati i nostri peggiori incubi, non solo quelle che disinnescano i nostri sogni proibiti. Ad esempio ci seducono e avvincono le immagini di morte, perché abbiamo bisogno di guardarle in faccia per poterle esorcizzare e stabilire su di esse una qualche forma di controllo: come si suol dire, per sconfiggere il nemico bisogna conoscerlo. Così, per quanto la nostra società faccia di tutto per allontanarle, le angosce primordiali e le paure ataviche ritornano a noi, proprio sotto forma di quei beni di consumo che tanto servono per distrarci dalle nostre inquietudini. Può sembrare paradossale, è vero, ma in realtà possiamo vedere all’opera quella che il già citato Jung, riprendendo un concetto di Eraclito, chiamava “enantiodromia”, ossia la funzione regolatrice dei contrari: una legge universale, che agirebbe tanto nella psiche umana individuale quanto in quella collettiva, che garantisce e preserva l’equilibrio della vita psichica. Lo psicoanalista svizzero riteneva che, qualora si verifichi nella coscienza umana una marcata unilateralità, con lo sviluppo massiccio e sproporzionale di un’istanza psichica rispetto ad un’altra (nel nostro caso la folle rincorsa del benessere ad ogni costo), questo non è immune da conseguenze: l’istanza tralasciata, relegata nell’inconscio, acquisisce sempre più energia fino, ad un certo punto, a prendere il sopravvento. In sunto, più si cerca di confinare qualcosa nell’oscurità, più questo qualcosa, per una sorta di legge di compensazione, torna alla ribalta con rinnovato vigore.
C’è poi da dire che l’arte spesso riesce a rendere belle violenza e sofferenza, sganciandole dagli aspetti più dolorosi e trasformandole in vere e proprie esperienze di piacere estetico. Il lato umano della faccenda è tralasciato, o quantomeno passa in secondo piano, per cui lo spettatore viene quasi desensibilizzato dinanzi ad eventi mostruosi e crudeli. Si pensi a tal proposito alle scene in cui Alex e i suoi Drughi compiono ogni sorta di brutalità e barbarie sulle splendide note della nona sinfonia di Beethoven; in alternativa, anche in questo caso, Tarantino ci fornisce numerosi spunti.

Poi sì, ammettiamolo, ci fa sentire meglio vedere le disgrazie e le sfighe altrui: rende la nostra vita quasi più bella, o quantomeno più accettabile; riusciamo persino ad apprezzarla meglio. È il piacere che nasce dal sentirsi lontani e protetti rispetto agli eventi indesiderati della vita. Non è per caso che gli anni a cavallo tra la fine del diciannovesimo e l’inizio del ventesimo secolo videro la portentosa diffusione dei freakshow, spettacoli circensi nei quali si esibivano persone dall’aspetto bizzarro e grottesco, affette da malformazioni congenite o malattie rare, che diventavano vere e proprie celebrità: i cosiddetti fenomeni da baraccone. Qui la spettacolarizzazione dell’anomalo e della deformità trovava il suo apogeo: la gente accorreva numerosa per vedere i mostri, mostri che, lontano dai riflettori del palco, altro non erano che i reietti della società, relegati ai confini del mondo e separati dagli altri, “i normali”. Il diverso era legittimato solo in quanto spettacolo, per la libera fruizione di una curiosità morbosa, ma sempre accuratamente a distanza dalla vita reale.
Oggi i freakshow non esistono più, soppiantati dall’avvento del cinema, ma alcuni meccanismi sono sempre gli stessi, possiamo esserne certi: sono solo cambiati i mezzi espressivi. Paradigmatici sono Real Time e trasmissioni come Malattie imbarazzanti o Vite al limite. Anche qui, come allora, il pubblico viene attratto dall’esibizione della diversità e dell’anomalia, sfruttando quel mix di curiosità, ribrezzo e sollievo che suscitano questi fenomeni sgraditi e lontani dalla nostra realtà.

A questo punto, per concludere, mi sembra doveroso spendere qualche parola a proposito di quando il gore sconfina nella vita reale, fuoriuscendo dal regno protetto della finzione.
Il riferimento è ovviamente agli snuff movie e alla quantità di materiale, amatoriale e non, che gira su internet mostrando torture e uccisioni reali; siti come rotten.com o bestgore.com ne sono un esempio. Ma non serve andare neanche così lontano, basta pensare al piacere voyeuristico per i dettagli più macabri ed inquietanti di cronaca nera che entrano quotidianamente nelle nostre case, e alla mania di certe trasmissioni televisive, in voga negli ultimi anni, di trasformare i casi di omicidio in serie tv a puntate, dove vince chi scova per primo l’assassino. In questi casi, negli spettatori agiscono presumibilmente gli stessi meccanismi descritti in precedenza: la ricerca di adrenalina, la sfida al limite, il sentirsi lontani dalle tragedie della vita. Qui, però, a dispetto di quanto avviene nella narrazione, sappiamo bene che quelle sofferenze, quella violenza, sono vere, reali. Il punto focale è proprio questo: spesso ci comportiamo come se non lo fossero. Guardiamo la scena con lo stesso distacco e interesse che avremmo di fronte ad un film o una serie tv. E credo che questo non si possa affatto disgiungere da un discorso più ampio che concerne la peculiarità della nostra epoca, dove i confini tra realtà e finzione, tra arte e vita sono sempre più sfumati ed indefiniti. Viviamo in una realtà sempre più volta a riprodurre e “scimmiottare” la finzione, ad assumere i caratteri propri del non-reale, ma soprattutto a farsi immagine: il sociologo francese Marc Augè la definisce “finzionalizzazione”, la messa in finzione della realtà. Basta guardarsi intorno. Basta guardare la miriade di reality e trasmissioni che affollano la nostra routine, dove le passioni ed i sentimenti umani sono artefatti creati ad hoc. In questo contesto, non c’è da stupirsi se anche la violenza reale diventa spettacolo.
D’altronde siamo una società voyeuristica. Cinema, televisione e mass media in generale ci hanno assuefatti a questo: a guardare senza alcuno stupore scene di morte e devastazione; a scrutare senza filtri nella vita delle persone, anche nella loro intimità, nel loro dolore. E forse finché non capita a noi, alla nostra cerchia ristretta, non ne rileviamo la sottile violenza. Perché il rischio è che lo sguardo impietoso si trasformi esso stesso in violenza, e soprattutto che il “guardare” diventi prioritario rispetto al “cosa guardiamo”. Ma il pericolo maggiore in agguato è forse un altro: che quello sguardo possa tacitamente acconsentire alla messa in atto e alla perpetrazione di crudeltà e soprusi, normalizzandoli. Il fatto stesso che ci sia qualcuno che guarda dei video contenenti sevizie e violenze reali ne giustifica implicitamente l’esistenza. Alejandro Amenábar esprime mirabilmente questi concetti con le immagini finali del suo film Tesis.
Comunque, al di là delle mie considerazioni personali, una cosa è certa: è intrinseco alla natura umana volersi guardare nel profondo e scoprirsi, fino agli abissi più oscuri, nei recessi più remoti e bui della propria anima, anche se quello che troveremo non è poi così confortevole. Homo sum, umani nihil a me alienum puto (Sono un uomo e ritengo che nulla di quanto riguardi gli uomini mi sia estraneo), diceva Terenzio, ed in tal senso “il gore” continua e continuerà a destare interesse. Non possiamo ignorare gli aspetti più infimi e degenerati del nostro essere umani. Che ci piaccia o meno, siamo anche questo.

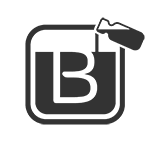





Leave A Comment